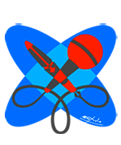Non avevamo molte cose in comune, anzi, direi quasi nessuna: lui studi di giurisprudenza (era avvocato) io di lettere, idee politiche diverse, carattere (lui aperto, facile all’entusiasmo), io all’opposto. Trovammo invece, fin dai primi incontri di giovani colleghi giornalisti, un interesse che ci avvicinò: la cronaca giudiziaria. Avevamo ottenuto dalla presidenza del Tribunale (quello storico di via Corte d’Appello, oggi adibito tra l’altro dal Comune per celebrare colorati e festanti matrimoni civili), una stanzetta spoglia – appena entrati dal portone di servizio in via San Domenico – che utilizzavamo come sala stampa, con alcune sedie, un tavolo e un telefono. Nient’altro.
Non avevamo molte cose in comune, anzi, direi quasi nessuna: lui studi di giurisprudenza (era avvocato) io di lettere, idee politiche diverse, carattere (lui aperto, facile all’entusiasmo), io all’opposto. Trovammo invece, fin dai primi incontri di giovani colleghi giornalisti, un interesse che ci avvicinò: la cronaca giudiziaria. Avevamo ottenuto dalla presidenza del Tribunale (quello storico di via Corte d’Appello, oggi adibito tra l’altro dal Comune per celebrare colorati e festanti matrimoni civili), una stanzetta spoglia – appena entrati dal portone di servizio in via San Domenico – che utilizzavamo come sala stampa, con alcune sedie, un tavolo e un telefono. Nient’altro.
DeVito dell’Unità, io della Stampa (dove anche lui sarebbe più tardi approdato), ci incontravamo tutte le mattine con Ito De Rolandis della Gazzetta del Popolo, Sauro Manca di Stampa Sera, e, talvolta con i colleghi delle Agenzie, della Tv, e, nelle grandi occasioni, con qualche inviato speciale spedito dalla propria testata a Torino per seguire un processo o un’inchiesta di importanza nazionale.
Mentre lui si muoveva tra aule e cancellerie con una certa dimestichezza, io avevo imparato a distinguere il pubblico ministero dal giudice a latere, il sostituto procuratore dal giudice istruttore, le aule della Pretura (in via Tasso) da quelle della Corte d’Assise e dagli uffici della Procura della Repubblica (in via Milano). Lui arrivava sempre di corsa “allora, cosa c’è oggi ragazzi?”, con un’aria da fratello maggiore anche se c’erano cronisti più anziani di lui. Parlo dei primi anni settanta, un mondo che si sta dissolvendo perfino nei ricordi.
Si sceglieva il processo che poteva valere una notizia o un pezzo, qualche appunto, due chiacchiere con i difensori o le parti civili, i cancellieri e i pm di udienza, e via, al caffè d’angolo con via Sant’Agostino. Di qui alla Procura, e , se proprio ne valeva la pena, alla Pretura.
Ma era solo in apparenza un’allegra comitiva di cronisti giudiziari: in ognuno di noi si annidava una piccola insidia, una furberia, talvolta il tradimento. Quel desiderio insopprimibile di portare qualcosa al giornale che avrebbe distinto il proprio pezzo da quello degli altri era sempre in agguato. Dare “un buco”. Ed era comprensibile, perchéognuno di noi aveva alle spalle, invisibile, il Capo, che a metà pomeriggio ti domandava “allora cos’hai oggi di bello, ragazzo”? Domanda banale e terribile che sottintendeva: mi porti la solita roba o hai nel taccuino una merce preziosa, il gioiellino nascosto che la concorrenza non ha?
Ecco: qui saltava fuori il carattere, il temperamento di Antonio. A questi giochini lui non ci stava: per lui il giornalismo, il lavoro, la vita erano una cosa seria, dal principio alla fine. Nessuna slealtà, nessuna doppiezza. Eravamo un gruppo? E allora si doveva procedere in gruppo. La figura del giornalista spregiudicato, pronto a tutto pur di avere una notizia in esclusiva, non gli apparteneva, non era nel suo Dna.
Il mestiere ci portò su strade diverse. Io lasciai la giudiziaria per altri incarichi di redazione, lui, pur continuando a fare il cronista e l’inviato, si dedicò con passione, la sua autentica passione, al sindacato, che proprio in quegli anni cominciava ad affrontare battaglie sempre più importanti e talvolta infuocate. Spesso Antonio era a Roma, negli organismi nazionali, e al ritorno lo attendeva la sua scrivania.
Ci incontravamo nei corridoi e negli uffici: qualche parola di simpatia, poi ognuno per la sua strada. La sua è sempre stata dritta, senza scorciatoie. Ha conosciuto conflitti, sofferenze. Quelle rare volte che me ne accennava, aveva fretta di chiudere lì, cambiare discorso. Mai una parola di sconforto, di cedimento. Accettava. Come fanno i veri uomini.
Ciao Devì
Sergio Ronchetti